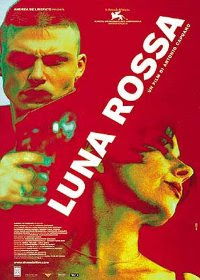«
Il mio istinto mi spinge a girare film che vorrei vedere, visto che nessun altro li ha diretti per me.» Parola di
Bong Joon-ho, giovane regista coreano (classe 1969) protagonista di una delle retrospettive più importanti del
Dong Fang, festival dedicato al cinema dell’Estremo Oriente. Terza edizione della rassegna (le due precedenti hanno focalizzato l’attenzione su Cina e Giappone), svoltasi a
Napoli – nella suggestiva cornice di Castel Sant’Elmo – tra il 25 ed il 28 ottobre. Film, mostre, incontri e musica per una visione a 360 gradi di una cinematografia viva e stimolante, quella della Corea del Sud.

Non solo i nomi noti che popolano i vari festival europei (Im Kwon-taek, Kim Ki-duk, Park Chan-wook, Kang Je-gyu). Soprattutto tanti giovani, interessanti autori tutti da scoprire. In primis
Bong Joon-ho. Cineasta colto, che fa della varietà stilistica la sua cifra caratteristica. Non a caso la personale a lui dedicata si intitola
Tempesta sui generi. Bong esordisce infatti nel 2000 con una sorta di black comedy,
Barking Dogs Never Bite (
Flandersui gae). Uno spaccato macabro e divertito della società sudcoreana, ricco di cinismo e toni surreali (un lettore universitario è ossessionato dai cani che popolano il suo quartiere, per porre fine al loro abbaiare escogita una ‘soluzione finale’ che non andrà a buon fine). Temi completamente ribaltati dall’opera successiva, il bellissimo thriller
Memories of Murder (
Salinui chueok, 2003): girato con stile livido, sorprendenti cenni ironici, è una pellicola che guarda al cinema americano (Bong dice di essersi ispirato a
Fargo dei fratelli Coen) seppur in un contesto tipico del suo paese (la provincia rurale di Hwaseong durante gli anni ’80, quando le tensioni sociali tra regime, polizia e movimenti di protesta si facevano pressanti). Un noir ispirato a fatti reali (un serial killer che uccide giovani donne), che tocca nel vivo il confronto tra due mondi opposti (poliziotti di campagna e poliziotto di città), gioca di sottrazione, resta sospeso nell’animo dei protagonisti e in quello degli spettatori. Elementi fondamentali che fanno da preludio a
The Host (
Gwoemul, 2006), ultimo (momentaneo) tassello di un percorso fantastico. Bong scopre infatti la sua ultima carta: gira un film di fantascienza apocalittica (o semplicemente un ‘film di mostri’ alla Ishiro Honda, stile Godzilla) inserendo nel plot (una famiglia sopravvissuta ad una strage causata da un mortale essere anfibio generato dall’inquinamento di una base americana a Seul) elementi incredibili, ridondanti effetti speciali digitali, satira politica, umorismo spiazzante, vite vissute ai margini. Il mostro è una sorta di ventre sempre gravido, elemento femmineo, una ‘famiglia’ nel senso ortodosso del termine. Cui si contrappone il nucleo di perdenti che abbandonato dalla società trova riscatto in un ultimo, disperato senso di solidarietà civile.

Non solo Bong Joon-ho ovviamente. Evento speciale è stato l’incontro transculturale tra musica e immagini elaborato dalle note del pianoforte di
Danilo Rea e i disegni di
Kim Dae-jong: un legame tra arti e culture diverse.
Uno sguardo approfondito ha poi dato la retrospettiva
Primavera coreana, otto film per conoscere meglio questa cinematografia, che ha vissuto sempre fasi alterne, tra momenti di gloria, successi clamorosi e dure repressioni politico civili. Dalla commedia tragico/sentimentale di
Kwak Jae-yong (
My Sassy Girl,
Yeopgijeogin geunyeo, 2001) al dramma teso e realista di
Jeon Soo-il (
With the Girl of Black Soil,
Geomen tangyi sonyeo oi, 2007 - presentato nella sezione Orizzonti di Venezia 2007). Passando dal ritratto (tremendo) di famiglia borghese dato da
Im Sang-soo in
A Good Lawyer’s Life (
Baramnan gajok, 2003) all’esperimento tra teatro, documentario e riflessione metacinematografica di
Shin Yeon-shick in
A Great Actor (
Joeun baewoo, 2005). Senza dimenticare il noir teso e avvincente di
Kwak Kyung-taek in
Friend (
Chingoo, 2001), il poetico e aggressivo spaccato sportivo messo in scena da
Ryoo Seung-wan in
Crying Fist (
Jumeogi unda, 2005), il sorprendente e spiazzante
Jealousy Is My Middle Name (
Jiltuneun naui him, 2002) di
Park Chan-ok (premiata per questo esordio ai festival di Pusan, Rotterdam e Tokyo), il melodramma pulsante di
April Snow (
Oechul, 2005) firmato
Hur Jin-ho.

Meritano una doverosa menzione anche le altre iniziative parallele del festival. Innanzitutto
Koreanimetion, cortometraggi d’animazione coreani che hanno fatto scoprire autori interessanti (tuttavia ancora acerbi: se la tecnica d’animazione digitale fa passi da gigante, mancano un disegno autentico e convincente e sceneggiature affascinanti - va citato però il memorabile
Existence (1999) di
Lee Myung-ha e
Elyn Park). Infine,
Altrasia: due finestre su Cina e Giappone incentrate su installazioni e videoproiezioni create dai giovani artisti tra videoart e manipolazioni digitali.